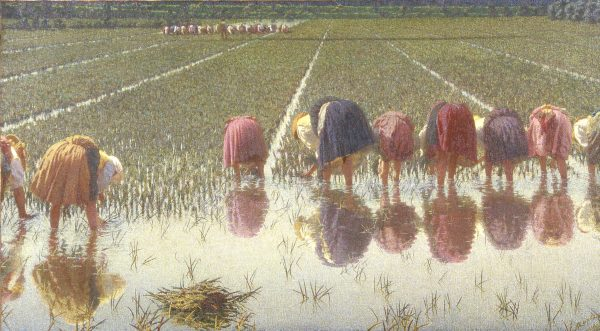
Donne che non si arrendono e che chiedono si apra un dibattito sullo stato del lavoro nei beni culturali. Siamo nella Parma neo-eletta “Capitale della Cultura 2020” e il caso è quello delle dieci operatrici museali che, dopo anni di contratti con inquadramento da uscieri, hanno rivendicato condizioni lavorative migliori. E proprio per questo hanno perso il loro posto di lavoro alla Fondazione Magnani-Rocca. Nell’articolo pubblicato da Linkiesta, è ben spiegato il faticoso iter del rapporto tra la Fondazione e le dieci storiche dell’arte che, oltre ad anni di studi e perfezionamento, hanno maturato una vasta esperienza nel settore. Si inizia dalle lettere d’incarico nel 2010. Poi, i contratti stagionali dal 2013, senza tutela se non il diritto di prelazione (“un obbligo di legge, non una concessione speciale” ci tengono a sottolineare). Infine, le richieste di regolarizzazione avanzate già dal 2014, tutte documentate da e-mail sempre ignorate, quando andava bene. Le poche risposte, infatti, erano condite di velate minacce, come “attente che le cose potrebbero anche peggiorare”. Il lavoro prosegue sottopagato, quindi, e con richieste di mansioni che vanno ben oltre l’inquadramento contrattuale da vigilante di sesto livello, cioè il più basso esistente: curatela dei cataloghi, visite guidate e allestimenti museali sono solo alcuni esempi di ciò che veniva loro affidato. Richieste puntualmente soddisfatte, nonostante tutto. Finché, un anno fa, le stesse operatrici intraprendono collettivamente un’azione sindacale. La reazione della Fondazione? Non è stata delle più concilianti, diciamo così, nei mesi successivi. Poi l’8 agosto il triste epilogo: “il suo diritto di prelazione è decaduto”. Traduzione: a settembre non verrete richiamate per la nuova mostra. Avete perso il lavoro. Che il diritto di prelazione fosse decaduto è scritto nel comunicato a mezzo raccomandata, recapitata a ognuna delle protagoniste di questa intervista. Un’intervista cui hanno risposto in gruppo e in forma anonima, per difendere la propria privacy.
Come vi siete sentite, quando avete ricevuto la raccomandata?
«Tradite. Ma non soprese. Sapevamo già da maggio che erano state contattate delle nuove operatrici, tramite una cooperativa bolognese. Perché, a differenza di quello che si è cercato di far passare, il senso di solidarietà tra noi lavoratrici è forte, c’è scambio di informazioni. Non vogliamo certo una guerra tra povere e nessuna ha mai messo in dubbio la professionalità delle nuove colleghe. Ma sappiamo che, se le nostre condizioni erano al limite dello sfruttamento, sicuramente le loro non saranno migliori. E pensa che una di noi è stata contattata da questa cooperativa, che ha selezionato il suo curriculum ritenendolo perfetto per l’incarico. Hanno fissato un colloquio ad agosto a Bologna ma, il giorno prima dell’incontro, una segretaria ha richiamato per annullare. Ufficialmente, avevano già individuato tutto il personale necessario. Del resto, la cooperativa di cui parliamo è famosa nel nostro settore per l’organizzazione discutibile, i molti appalti, i bassi salari e le tante cause in corso».
A proposito di cause, si dice abbiate impugnato il contratto solo perché “reclamate un indeterminato” e non tenete conto delle gravi difficoltà economiche della Fondazione.
«Non accettiamo che si cerchi di annebbiare il giudizio con questioni burocratiche non pertinenti. Non abbiamo mai “preteso”. Abbiamo avanzato richieste legittime, cioè il giusto riconoscimento del nostro lavoro e una tutela minima dei nostri diritti. Siamo storiche dell’arte, siamo professioniste preparate, serie, volenterose, abbiamo da sempre fatto molto per la Fondazione, abbiamo creduto nel progetto, abbiamo investito il nostro tempo e le nostre competenze per contribuire a farne un centro museale di successo. È vergognoso, irrispettoso e soprattutto ingiusto, dopo tutti questi anni, essere trattate come bambine capricciose».
Però, se i soldi non ci sono…
«È l’unica risposta che abbiamo sempre ottenuto. Peccato che la domanda non sia mai stata quella. Tanto per cominciare, la Fondazione dichiara di essere in stato pre-fallimentare, ma non è stato possibile accedere a dei dati. Va ribadito, poi, che le nostre richieste non riguardavano solo un aumento salariale, ma il rispetto dei diritti. Inoltre, nel corso degli anni, abbiamo avanzato anche delle proposte di crowdfunding. Tutte respinte. E abbiamo collaborato alla realizzazione, ad esempio, del nuovo catalogo, venduto a 30 euro a copia, e per il quale abbiamo percepito 24 euro lordi a scheda. Scrivere una scheda di un’opera significa fare un lavoro di ricerca e documentazione storico artistica che, a essere approssimativi, richiede almeno 3 giorni: fanno 8 euro al giorno per un compito che solo un professionista del settore può svolgere».

Al di là del famigerato compenso in visibilità, mettere la propria firma su un catalogo prestigioso non è un traguardo importante?
«Lo sarebbe se effettivamente comparissero le nostre firme. Invece, tutti i nostri nomi sono spariti dall’elenco delle curatrici museali quando ancora eravamo in servizio. Siamo diventate fantasmi. Per di più, nonostante il catalogo fosse già stato revisionato, approvato e pronto per la pubblicazione, quando a maggio 2018 sono finalmente arrivate le copie (che tra l’altro non ci sono state fornite, neanche in pdf, perché potevamo “continuare a studiare su quello vecchio”), abbiamo scoperto che tutte le schede scritte da noi erano state rimosse o sostituite».
Com’è possibile?
«In pratica, il lavoro che abbiamo svolto riguardava sia opere di cui già esisteva una scheda da aggiornare, sia opere mai catalogate. La nuova pubblicazione, in teoria, avrebbe dovuto contenere il catalogo aggiornato e completo della Fondazione. Invece, al posto delle nostre schede sono state stampate quelle vecchie, quando c’erano, altrimenti niente: in altre parole, hanno preferito lasciare il catalogo incompleto e non aggiornato, piuttosto che inserire il lavoro per cui ci hanno pagate».
Ma questo non va a discapito della Fondazione stessa?
«Infatti, non ha senso. Come del resto non ha avuto senso, negli ultimi mesi, impedirci di effettuare le visite guidate a gruppi di meno di dieci persone che, nonostante pagassero come tutti gli altri, venivano lasciati nelle mani degli studenti in alternanza scuola-lavoro. O come non ha senso vietare la presenza di sedie né per noi, che facevamo anche nove ore di seguito in piedi, né per i visitatori, spesso anziani, perché “non sono eleganti” (sic.). O come non ha senso che una sede espositiva di questo livello non garantisca il reale accesso ai disabili: la ghiaia dell’ingresso rende il passaggio delle sedie a rotelle davvero complicato, eppure delle soluzioni ci sarebbero, fanno parte delle proposte inascoltate… ma tanto in effetti le sedie a rotelle non possono in nessun modo accedere al primo piano, dove ad esempio erano esposte le celebri Ninfee di Monet. La Villa dei Capolavori… del surrealismo!».
In che modo avete cercato di far valere la vostra posizione?
«Oltre ai vari tentativi con il Direttore, a giugno abbiamo interpellato anche i membri del CdA, di cui fanno parte, tra gli altri, le più alte cariche istituzionali del territorio: vescovo, rettore, prefetto, sindaci di Parma e Traversetolo, direttore della Galleria Nazionale, responsabile biblioteche, ecc. Abbiamo fornito a tutti loro un quadro molto dettagliato della situazione. L’unico a dare qualche segno di vita, e solo dopo una telefonata della nostra sindacalista, è stato il sindaco Pizzarotti, il quale ha dichiarato di non saperne nulla e che si sarebbe informato. A dirla tutta, è stato più veloce a rispondere a un commento su Facebook che non alla Pec (e-mail di posta certificata, ndr)».
E il sindacato cui vi siete rivolti che tipo di risposta ha avuto dalla Fondazione?
«Il sindacato è stato ostacolato fin dall’inizio. Siamo nel febbraio 2018, quando finalmente viene concesso un incontro con Presidente e Direttore: il primo presenza sempre nell’ombra, mentre con il secondo abbiamo avuto un rapporto professionale quotidiano. Al suo arrivo, la nostra sindacalista trova al tavolo un altro sindacalista, di un’altra sigla e convocato dallo stesso datore di lavoro! La persona in questione pretendeva di condurre la trattativa senza alcuna delega da parte nostra ed era già pronto a firmare l’accordo contro la nostra volontà. Come del resto ci aveva convinte a fare già qualche anno fa, spergiurando che le cose sarebbero migliorate. Ma sai com’è, la prima volta ci credi, la seconda e la terza pure. Poi ti senti presa in giro. Comunque, hanno dovuto litigare per mandarlo via. E non dimentichiamo la consulente del lavoro della Fondazione, che nel trambusto si lamentava: “Ah, queste ragazze… fanno tanto preoccupare il dottore e il professore!”».
Se le condizioni sono sempre state queste, perché siete rimaste?
«È la stessa domanda che si fa alle donne tradite, che scelgono di fidarsi del compagno e poi alla fine lui scappa con la segretaria, non trovi? La risposta forse è la stessa che dà chi si trova in quella situazione. Per passione. Perché è per questo che abbiamo studiato, ci siamo laureate e specializzate, a differenza di chi ora decide del nostro destino professionale. Insomma, è il lavoro in cui crediamo: l’arte e la bellezza autentica hanno un valore enorme e richiedono responsabilità, oltre che competenza. È il sogno a cui vogliamo credere, che vogliamo vedere realizzato. Vogliamo che Parma sia capitale della cultura non solo nel 2020, ma ogni giorno. Ed è qualcosa che ogni cittadino dovrebbe pretendere».
In conclusione, qual è il messaggio per voi importante da lanciare?
«Noi siamo state lasciate a casa per aver alzato la testa, per non aver scelto il silenzio, che è la strada più comune (e purtroppo comprensibile) in situazioni come queste. Se avessero voluto tenerci, avrebbero aperto un tavolo di contrattazione. Avrebbero potuto dirci “vi offriamo quello che possiamo, ma rispettiamo e diamo valore al vostro lavoro”. Ma non c’è mai stata né la volontà di aprire questo tavolo né un atteggiamento rispettoso. Dieci anni fa, forse, avevamo ancora l’ingenuità di pensare che, dopo tanti sacrifici e fatica, sarebbe arrivata una ricompensa. Ora sappiamo che accettare queste forme di schiavitù non ha alcun senso, perché in questo modo si lascia credere a chi comanda di poter continuare indisturbati lo sfruttamento. Bisogna dire basta. Dire no. Fin da subito. Noi abbiamo osato sfidare il potere, e l’arroganza del potere ci ha punite e spazzate via. Adesso ci ritroviamo disoccupate e amareggiate, ma non certo sconfitte o rassegnate. Lotteremo perché una situazione così non si ripeta, per nessuno, in nessun luogo. Lotteremo per la Bellezza, sì. Quella di un lavoro dignitoso».
