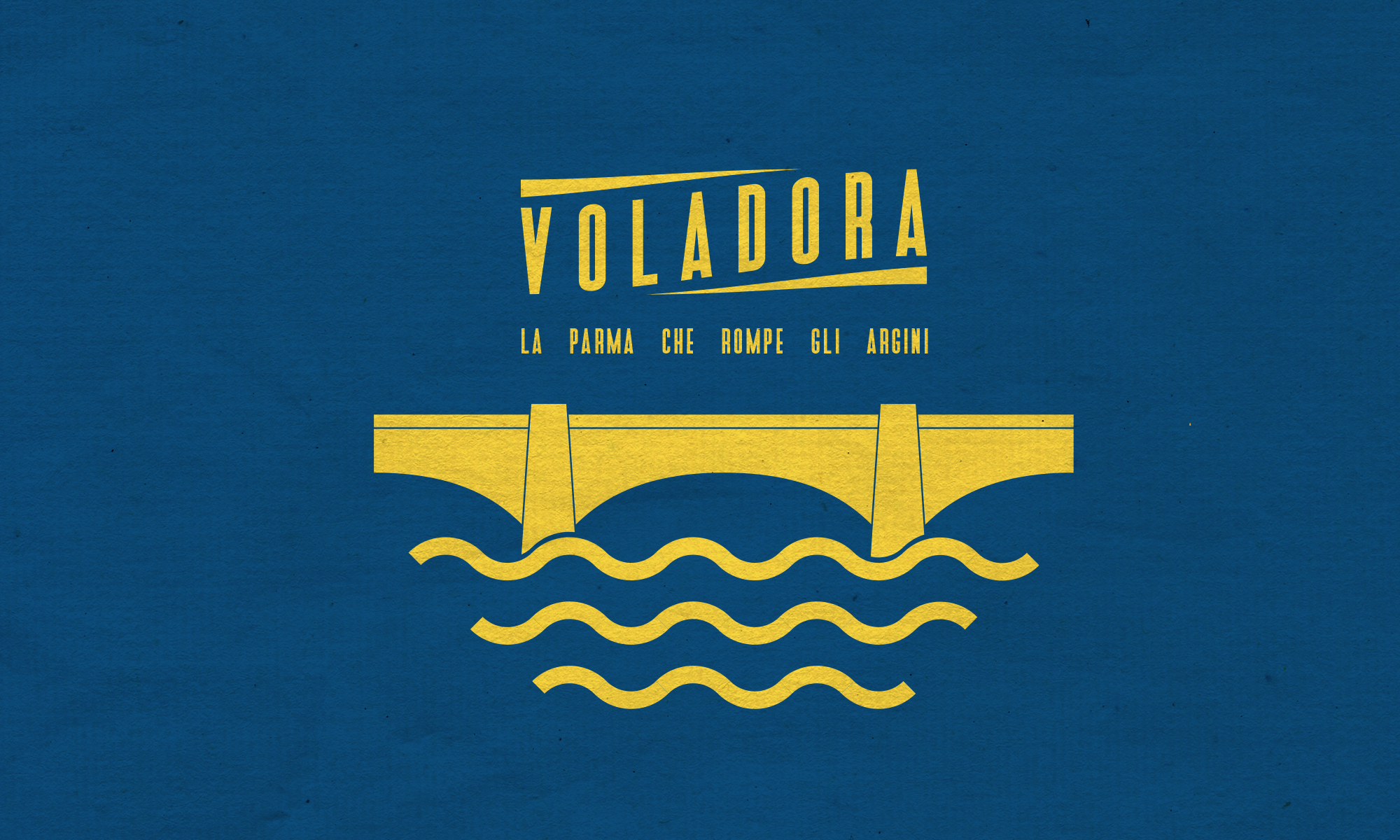di Elisabetta Salvini
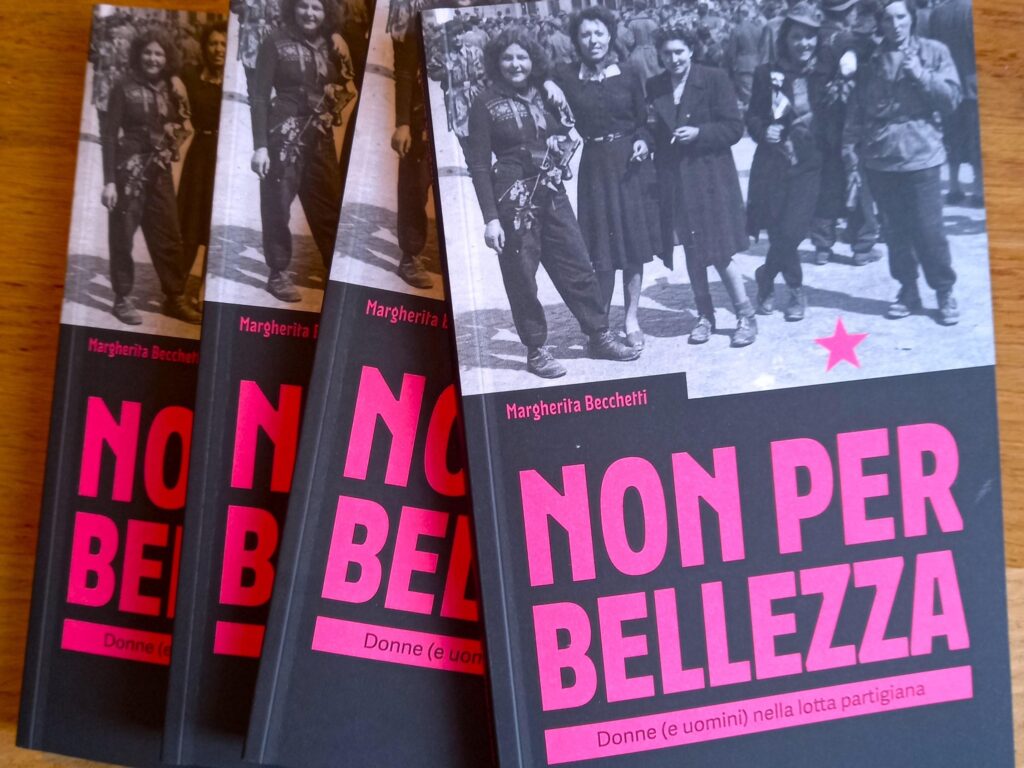
Scrivere del libro di Margherita Becchetti, Non per bellezza. Donne (e uomini) nella lotta partigiana, edito da Mup nell’aprile del 2025, significa, per me, scrivere del libro di un’amica/sorella e compagna di scelte ed è insieme la cosa più facile e più difficile che ci sia.
Facile, perché le parole di chi condivide i tuoi stessi percorsi di studio e il tuo stesso sguardo sul mondo sono anche le tue. E in quelle parole ti ci metti comoda, ti ci ritrovi e il sentirle così vicine le fa inevitabilmente sembrare giuste, quasi fossero le sole possibili, le sole in grado di restituire quella quelle storie, quelle vite, la storia.
Tuttavia, per le stesse ragioni, diventa anche difficile. Perché la riconoscenza è uno strano motore che rischia di ridurre la lucidità necessaria per porsi domande e, se serve, criticare, prendere le distanze.
Io, l’ammetto, quest’operazione non l’ho fatta, non ne sono stata capace. Durante la lettura di queste pagine non ho mai preso le distanze.
Emozione, riconoscenza, gratitudine, ammirazione e vicinanza è ciò che ho provato leggendo le vite delle donne che animano questo libro. E dentro ci ho letto anche la vita di un’amica preziosa che non si risparmia mai e che, nei suoi studi ci mette sé stessa con intelligenza, passione, generosità e con una lungimiranza politica che non so riconoscere in nessun altro, come in lei.
In questo libro ci sono le partigiane, certo, ma prima di tutto c’è Margherita Becchetti. C’è la sua fatica, la sua abitudine al racconto storico, allenata e consolidata da anni di narrazioni fatte in strada, nelle piazze, nei borghi dell’Oltretorrente. C’è la sua ostinazione nel voler raccontare la storia al mondo che sta fuori dall’accademia, ai non addetti al lavoro. C’è il suo non accontentarsi e il suo ricercare ogni volta, un modo nuovo e credibile, per trasformare una potenziale lezione in una narrazione mai accademica, mai cattedratica. C’è la consapevolezza di chi sa che per appassionare serve il rigore scientifico della ricerca, ma il linguaggio sporco della quotidianità, uniti ad una passione che solo chi davvero ama profondamente ciò che fa possiede.
Per chi ha avuto la fortuna di scoprire un pezzo di Parma in una delle tantissime visite guidate di Margherita Becchetti, leggere questo libro avrà lo stesso sapore. Le parole, sebbene scritte, sono così vive da assumere la cadenza della sua voce e tra una riga e l’altra sarà possibile anche immaginare il suo gesticolare intelligente, il suo toccarsi la punta del naso, quasi a strofinare una sorta di lampada magica, dalla quale non esce alcun genio, ma piuttosto i suoi pensieri profondi, lineari, chiari, mai banali.
Non per bellezza. Donne (e uomini) nella lotta partigiana è la fatica di una femminista, una donna adulta che interroga il passato con la precisa volontà di consegnarlo al presente e di renderlo materia di vita, prima ancora che di riflessione e confronto, per le donne più giovani, chiamate oggi a combattere le loro battaglie in un mondo che è ancora fatto, pensato, costruito e agito da uomini.
Con questo libro Margherita Becchetti parla a tutt3 noi. Alle tante generazioni di donne e di uomini che sono venute dopo quei venti mesi di lotta di Liberazione e lo fa facendosi guidare da domande nuove. Le domande sue.
Da cinquanta anni a questa parte, la Resistenza femminile è stata raccontata seguendo categorie storiche precise, ripetute. La Resistenza taciuta e negata, delle storiche Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, la resistenza senza armi e il maternage di Anna Bravo. Categorie che da tracce interpretative sono diventati solchi profondi e poi sensi unici per chiunque voglia parlare di resistenza, guerra e donne. Margherita Becchetti quelle categorie le conosce bene, le abita, ma capisce che non le bastano più e così esce le scaravolta ed esce dal solco, per andare oltre.
In questo libro c’è, dunque, molto d più del tentativo di stabilire, quantificare e validare quanto e cosa hanno fatto le donne in quei venti mesi di lotta per la libertà. Quello è già stato fatto da altre, prima. Ora serve altro.
Serve lo sguardo di Margherita Becchetti, attento ed allenato a frugare nelle relazioni tra i generi, per fare emergere le differenze concrete che c’erano – e ci sono – tra l’essere maschi e l’essere donne, e non solo nella Resistenza. E ancora di più serve la tenacia di provare a leggere tra le righe, per comprendere quali siano stati i tentativi messi in atto da donne e uomini per cercare di tenere insieme e sullo stesso piano, due universi allora più che mai lontanissimi, sovvertendo ruoli imposti e pregiudizi radicati da secoli. Leggere la Resistenza con queste lenti lascia affiorare le tante difficoltà che le donne hanno dovuto affrontare e il prezzo che hanno dovuto pagare per stare dentro alle relazioni e alla storia in modo libero e alla pari.
Leggerete questo nel libro di Margherita Becchetti e lo farete passando attraverso sette capitoli che racchiudono in fasi evocative e significative le vite delle tante donne tutte protagoniste del libro: scegliere, trasgredire, pregiudizi, senza armi, il male, crescere, il dopo.
Tra i capitoli non saprei scegliere quale o quali siano i miei preferiti, ma fin dalla prima lettura, mi ha incuriosito la scelta di due verbi in particolare: trasgredire e crescere. Entrambi verbi intransitivi e dunque, per loro natura, solo attivi. In un mondo in cui le donne erano abituate ad essere proprietà degli uomini e passive, avviene qualcosa di straordinario che Becchetti raccoglie e racconta anche nella scelta di verbi che non possono e non vogliono essere usati nella diatesi passiva. In questi verbi intransitivi sta la dirompenza della Resistenza e del libro. Nel raccontare di una scelta che è trasgressione e crescita insieme e che trasformerà le donne dall’essere passive ad attive, affrontando i pregiudizi, sfidando il patriarcato, imponendosi al paternalismo dei compagni, all’eterna infantilizzazione femminile e resistendo al male –tanto e atroce – di una guerra che ha scaraventato sui loro corpi anche la violenza più tremenda, quella dello stupro, usato sistematicamente come arma di defraudazione, umiliazione o come bottino per i soldati. Una trasformazione che richiede loro di fare i conti con la propria moralità, con i sensi di colpa, le inadeguatezze, le rinunce, i divieti interiori, ma che le porterà a ricostruirsi, seppure con difficoltà, per percepirsi in modo nuovo, riconoscendosi, come dice Santina Dusi, la capacità di “poter fare”, di “prendere a pensare in grande”, come racconta Marisa Ombra, o semplicemente di poter crescere, come scriverà in una lettera Velia Sacchi al suo papà, “anche se trovo coperchi da tutte le parti”. Ecco, Margherita Becchetti, con questo libro, ha cercato di togliere qualche coperchio per aiutare tutt3 noi a crescere ancora un po’.