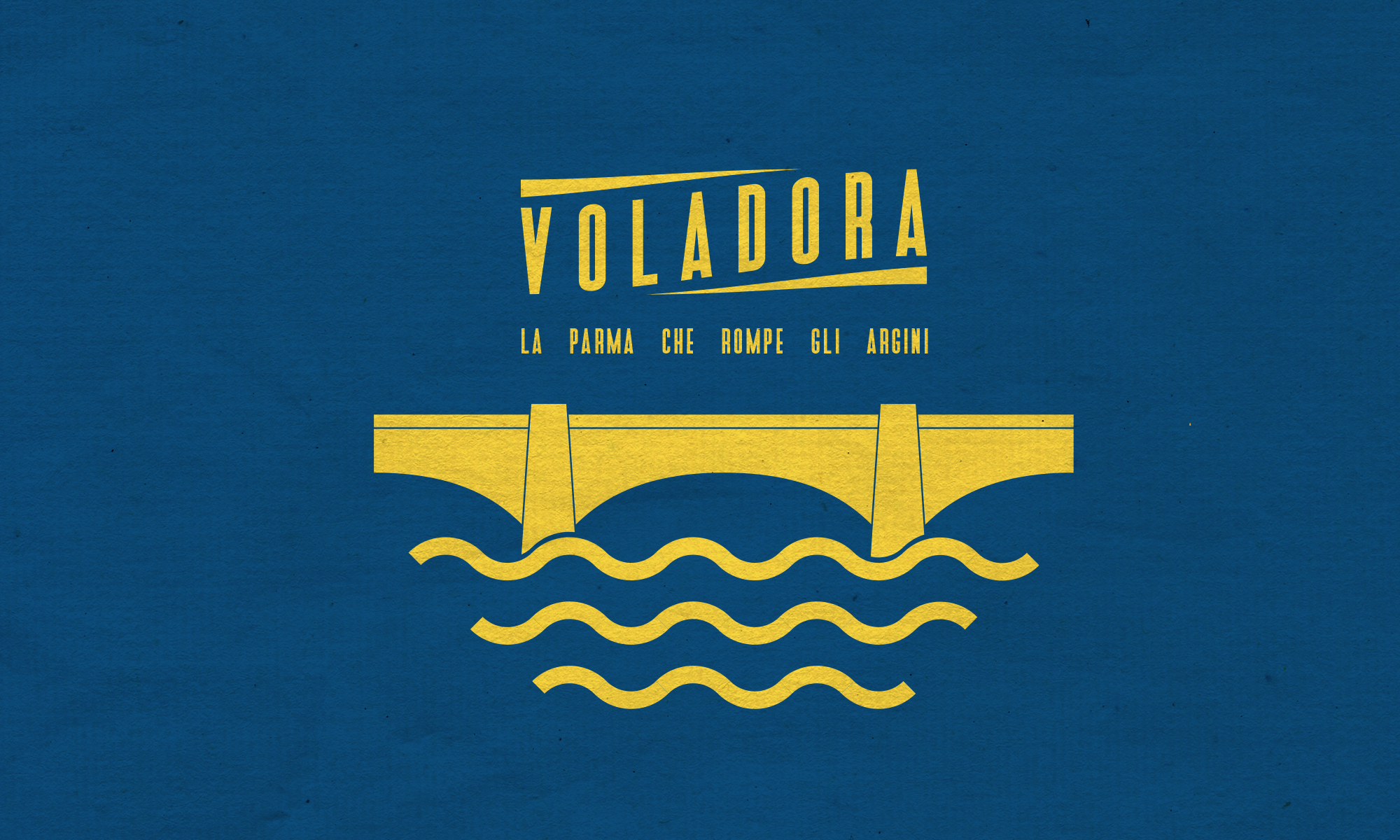di Matteo Battilani

Mercoledì scorso è iniziato a Parma il corso della Libera Università del Sapere Critico (LUSC) di introduzione al pensiero marxiano che proseguirà fino al 5 febbraio. Tra i relatori anche Matteo Battilani di cui pubblichiamo un intervento (ndr).
“Lo sviluppo della grande industria toglie dunque di sotto i piedi della borghesia il terreno sul quale essa produce e si appropria dei prodotti. Prima di ogni altra cosa essa produce i suoi becchini. Il suo tramonto e la vittoria del proletariato sono egualmente inevitabili”.
Una cosa è certa, quando nel 1848 Marx ed Engels preconizzavano l’imminente vittoria del proletariato, ai due autori non mancava una buona dose di ottimismo. Va detto che non era una fiducia del tutto immotivata: i moti della “primavera dei popoli” scoppiarono appena due settimane dopo la pubblicazione del Manifesto del partito comunista, e nonostante gli esiti differenti da quelli prospettati dai due autori, non si può dire che la previsione di un’incombente rivoluzione fosse infondata.
Una decina di anni dopo, in occasione della crisi commerciale del 1857, Marx immaginò che potesse scoppiare una seconda ondata rivoluzionaria, ma anche in questo caso le sue rosee previsioni si sarebbero scontrate con una “cattiva realtà” (per dirla hegelianamente). In quegli anni, lavorando a quelli che sarebbero stati chiamati “i quaderni della crisi”, giunse alla stesura di Per la critica dell’economia politica, una sorta di prologo al suo lavoro più noto, il Capitale. Nella prefazione si può leggere “l’umanità si pone sempre e soltanto quei problemi che essa è in grado di risolvere”. Anche questa affermazione fiduciosa, come quella precedente, ai giorni nostri non può non essere letta con un certo scetticismo.
Negli anni successivi, soprattutto dopo la Comune di Parigi, Marx si convinse che la fine del sistema capitalistico non sarebbe stata imminente. Tra i vari aspetti che caratterizzano la sua maturazione intellettuale, forse, va annoverata anche la realizzazione che la classe lavoratrice non stava correndo i cento metri, ma una maratona. Non la disillusione, dunque, ma una più ponderata analisi concreta della situazione concreta.
Oggi, all’opposto del giovane Marx, siamo portati a leggere le contraddizioni del presente in modo antitetico, ovvero con un profondo pessimismo e con rassegnazione. La guerra, la crisi economica e la possibilità di una catastrofe climatica ci fanno pensare al peggio, ma si tratta di un approccio specularmente fallace rispetto all’entusiasmo ottimista. Nelle epoche di crisi, scriveva Eric J. Hobsabwm, “l’isteria e l’assenza di senso storico si combinano”. Per questo motivo, di fronte a un futuro infausto a cui ci sembra di essere già condannati, la passività rischia di prendere il sopravvento.
Leggere Marx oggi è particolarmente difficile anche per questo nostro differente modo di rapportarci con le contraddizioni del presente. Siamo portati a leggere l’ottimismo di Marx come ingenuità e quindi a sottovalutare le sue lucide considerazioni analitiche come un mero prodotto della “speranza”, questi due piani invece si devono separare. Ma c’è di più. Facciamo fatica anche a interpretare quanto scritto da Marx immaginando anacronisticamente le nostre incertezze in un’epoca anteriore. Chi scrive ricorda della prima volta in cui, leggendo il Manifesto, fu portato a interpretare in modo improprio il seguente paragrafo:
“Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri di corporazione e garzoni, in una parola oppressori e oppressi sono sempre stati in conflitto tra loro, hanno sostenuto una lotta incessante, a volte occulta a volte palese, una lotta che si è sempre conclusa o con una trasformazione rivoluzionaria dell’intera società o con la rovina comune delle classi in lotta”.
Una prima lettura può portare a pensare che Marx avesse seriamente preso in considerazione l’ipotesi della catastrofe, oggi più che mai attuale. Il verbo al passato (si è sempre conclusa) può sciogliere questo dubbio: probabilmente il riferimento era al crollo del mondo romano, un antagonismo di classe che non condusse a una trasformazione rivoluzionaria. Potrebbe sempre trattarsi di una frase retorica, ma è fuori discussione che nel 1848 Marx considerasse seriamente la possibilità della “rovina comune” nel senso in cui siamo portati a intenderla oggi.
Oltre all’ipotesi della catastrofe, Marx non prese mai in considerazione l’idea – oggi egemone – della “fine della storia” con il sistema capitalistico. Dotato di un profondo senso storico, considerò giustamente il capitalismo come un sistema transitorio e non eterno, al pari di ogni altro sistema socioeconomico esistito sino ad allora. Forse – si potrebbe obbiettare – fu troppo fiducioso nei confronti della possibilità di un passaggio imminente a una società superiore, ma non si possono considerare meno ingenui (e ottimisti) coloro che ancora oggi continuano a parlare del sistema attuale come dell’unico (e migliore) dei mondi possibili. Esattamente come la rassegnazione pessimista di fronte a un futuro nero, la convinzione panglossiana di vivere al culmine del progresso della civiltà è almeno altrettanto antistorica e infondata.
Fatte queste considerazioni, occorre aggiungere una cosa. Marx, nonostante l’ottimismo giovanile, non immaginò mai che il passaggio storico verso una società postcapitalistica potesse avvenire “naturalmente”. Il trapasso verso il nuovo modo di produzione sarebbe dovuto avvenire attraverso l’azione cosciente e organizzata del proletariato. Il materialismo storico, o come l’avrebbe definito Gramsci “la filosofia della praxis”, si fondava sull’impegno politico e rivoluzionario, un impegno che Marx non avrebbe mai abbandonato neppure nella più rilassata maturità.
È questa, secondo noi, la ragione fondamentale per cui occorre leggere Marx oggi: perché non fu solo un dottore prussiano in filosofia, ma un rivoluzionario. Indipendentemente dalle previsioni ottimistiche o pessimistiche, la sua teoria critica orientata all’azione è la ragione per cui molti furono portati, e sono portati tutt’oggi, a considerarlo con grande attenzione. Marx fu uno dei pochi pensatori che riuscì a coniugare teoria e prassi in modo armonico, considerando le due sfere come intimamente collegate. Non un appassionato volontarismo – cosa che lo avrebbe inorridito – ma la consapevolezza del fondamento materiale dell’attività politica umana, e quindi anche della propria, e la coscienza della necessità di una comprensione del mondo per poterlo cambiare.
Leggere Marx oggi non significa rapportarcisi acriticamente e dogmaticamente, che peraltro implicherebbe considerarlo come un pensatore compiuto quando andrebbe considerato come “un cantiere aperto”. Siamo convinti che non si possano affidare a Marx le nostre speranze messianiche considerandolo come un profeta da “difendere” contro eretici e infedeli. Allo stesso modo, non si può leggere Marx come tentarono di fare in molti, Schumpeter per primo, cercando di separare meccanicamente le sue considerazioni analitiche, lucide e profonde, dalla sua militanza, inutile o dannosa. Si tratta piuttosto di comprendere cosa ha ancora da dire oggi Marx a coloro che si pongono il problema di interpretare e di trasformare la realtà, da entrambi i punti di vista. In un periodo di crisi e di tensioni come quello attuale è quanto mai necessario porsi questo duplice problema (l’interpretazione e la trasformazione) senza scadere nell’immotivato ottimismo o nell’irragionevole rassegnazione. Anche perché, se realmente si presentasse l’ipotesi della “rovina” della società, non resterebbe nient’altro da fare che trasformala, e per quel momento sarà meglio aver fatto i conti con questo ineludibile pensatore e rivoluzionario.
Leggi anche Capitalismo precario di Francesco Antuofermo
Leggi anche Karl Marx: un maldestro profeta o un pensatore ancora attuale? di Andrea Palazzino