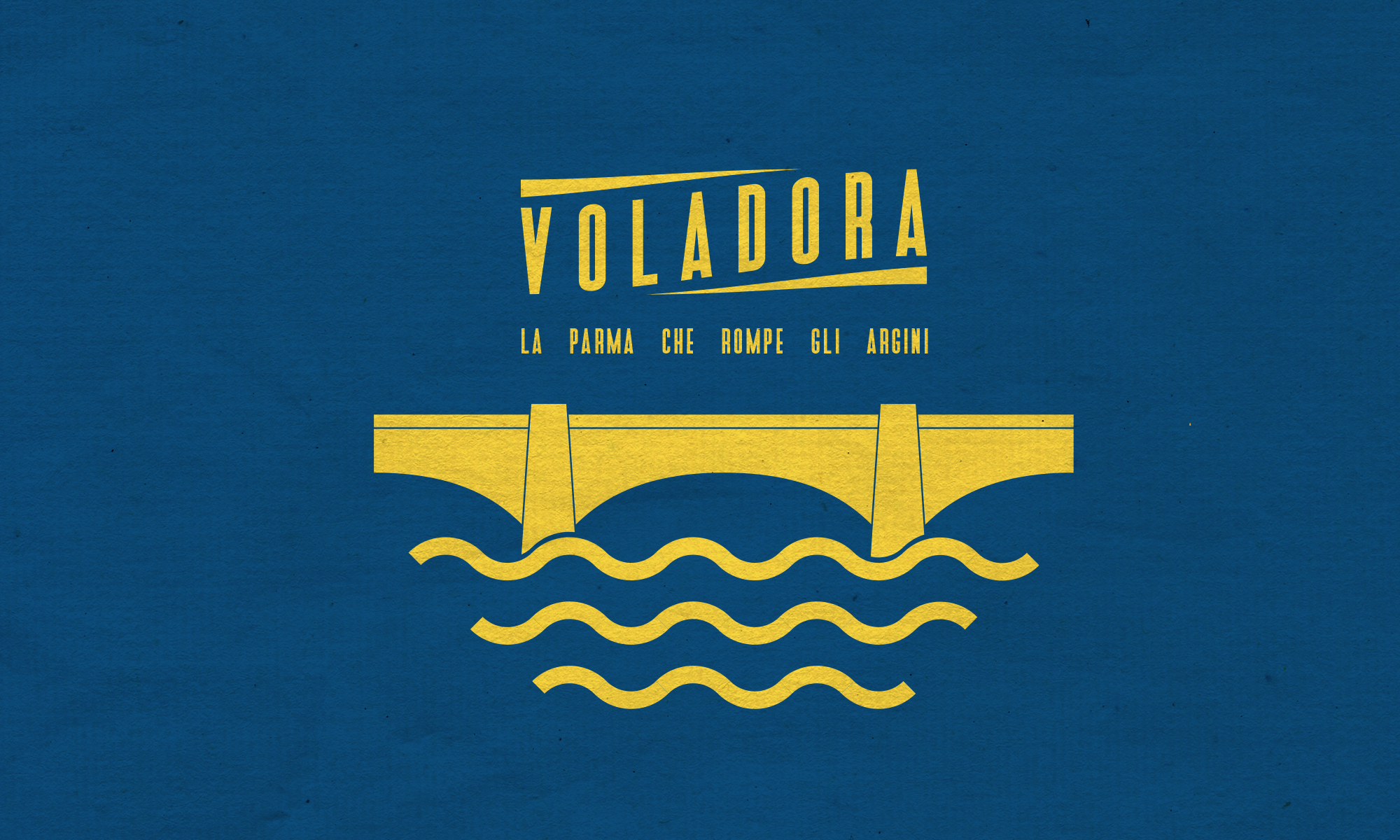di Marco Baldassari
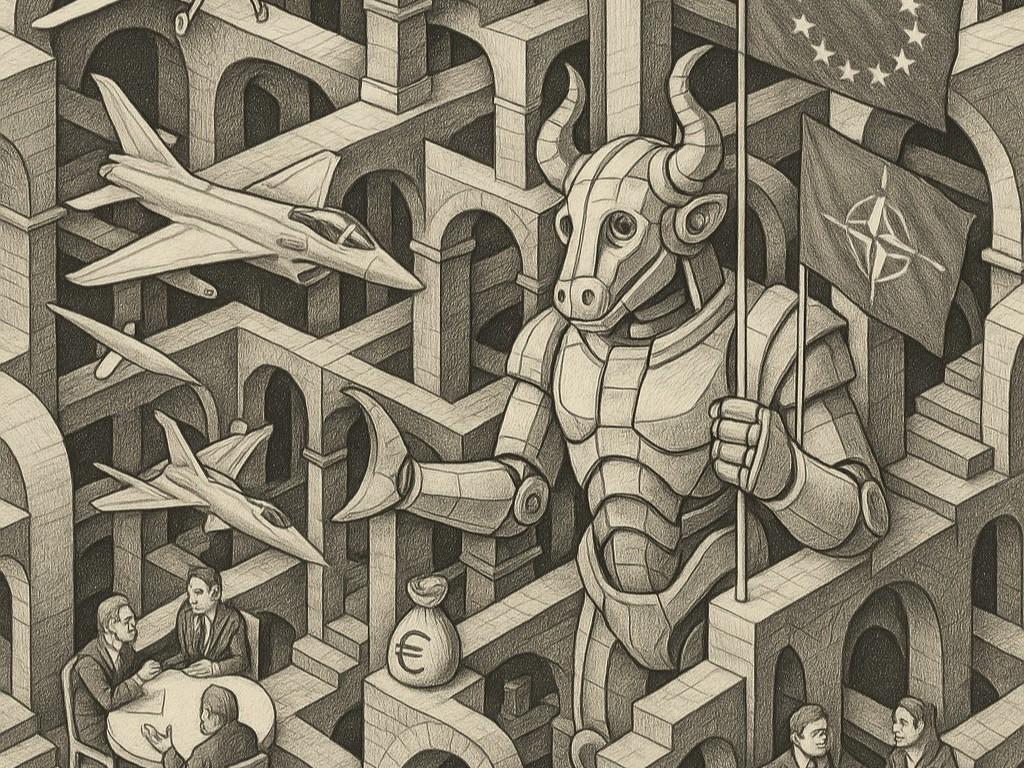
“L’Europa politica è in stallo. Le retoriche dell’integrazione sembrano svuotate, mentre crescono le fratture tra centro e periferie, tra governance e rappresentanza. Un pericoloso e cieco rilancio attraverso il riarmo sta adombrando il vecchio continente”. Di questi temi tratta il corso che inaugura il nuovo anno della Libera Università del Sapere Critico e ha come titolo Nel labirinto dell’Unione europea. Storia e critica dell’ideologia europeista curato da Marco Baldassari. Gli incontri saranno 4 da martedì 28 ottobre al 18 novembre dalle 18.30 alle 20 alla Casa delle donne di Parma (via Melloni 1). Per iscrizioni o informazioni lusc.csm@gmail.com.
Uno spettro si aggira per l’Europa: la russofobia e la retorica del riarmo. La costruzione del nemico, insieme allo “stato di eccezione” (la crisi per la sicurezza), rappresentano gli strumenti politici attraverso cui le classi dominanti cercano di affrontare la crisi del capitalismo e del suo processo di accumulazione. In questo senso, il passaggio dall’austerity al warfare che caratterizza gli ultimi quindici anni appare del tutto consequenziale e coerente con i tentativi di puntellare un edificio comunitario in fase di dissoluzione. Un declino che riguarda tanto l’UE quanto i suoi Stati membri, considerati singolarmente. Il destino che li accomuna all’interno di questa gabbia neoliberale del “vincolo esterno” è lo stesso che, in Italia in particolare ma non solo, si manifesta con un neoliberalismo conservatore, reazionario e antisociale: la variante “alt-right” di quello progressista, altrettanto esiziale e antidemocratico. Si potrebbe definire, a tutti gli effetti, un “liberalismo autoritario”.
L’Unione europea, nel corso degli ultimi decenni, si è configurata come un dispositivo istituzionale capace di trasformare in profondità le modalità di esercizio del potere statale. Il processo di integrazione, spesso narrato come un destino lineare, è stato in realtà un campo conflittuale: uno spazio in cui si è giocata una rinegoziazione costante tra sovranità nazionale e potere sovranazionale, tra rappresentanza democratica e razionalità tecnica, tra unità e differenza. La costruzione europea, lungi dall’essere una “architettura neutrale”, ha operato come un paradigma normativo: ha selezionato obiettivi, delimitato spazi di decisione, costruito un linguaggio politico che ha finito per oscurare le alternative. Concetti come “governance”, “coesione”, “solidarietà” sono stati impiegati come categorie assiomatiche, sottratte al conflitto politico. Il risultato è un’Unione che gestisce senza decidere, che amministra senza costituire, che legifera in assenza di una vera legittimazione popolare.
La crisi del paradigma integrazionista
Oggi ci troviamo davanti a una crisi strutturale del paradigma integrazionista. Le recenti accelerazioni – dal Next Generation EU alle strategie per la difesa comune Readiness 2030 – non rappresentano una rottura con la logica dominante, ma piuttosto il suo aggiornamento: la riproposizione di un’integrazione tecnica, presentata come soluzione necessaria alle sfide globali.
Tuttavia, oggi l’Europa si trova costretta a politicizzarsi. La retorica della resilienza, della doppia transizione (verde e digitale), dell’autonomia strategica non può più funzionare da semplice schermo ideologico. La doppia crisi, di accumulazione e geopolitica, impone di ripensare l’Unione non più come un progetto meramente funzionalista, ma come un sistema di sicurezza collettiva. È questa la retorica della “sovranità europea” declamata da figure come Draghi e Padoan, e che il mondo federalista – così come ingenuamente una parte del ceto medio – continua ad auspicare: “Ci vuole un’Europa più forte!”, “Servirebbe davvero una difesa comune, il problema è che siamo divisi”, e così via.
Eppure, questa “politicizzazione”, come molti hanno osservato – a partire ad esempio da Barbara Spinelli, figlia del celebre federalista celebrato come padre fondatore dell’Europa unita – non è altro che una forma di atlantismo, che ribadisce la subordinazione agli Stati Uniti. Alla retorica di un europeismo travestito da atlantismo, la risposta più autenticamente europea è arrivata invece dalle 44 barche della Global Sumud Flotilla (liquidate con sufficienza dalle istituzioni europee) e dalle mobilitazioni oceaniche degli ultimi giorni.
A questa politicizzazione – i cui effetti nefasti e autodistruttivi si sentiranno presto – si rende necessaria la possibilità stessa di ripensare la forma politica dell’Europa. La scelta che abbiamo davanti non è semplicemente tra “più Europa” e “meno Europa”: oggi la prima opzione è occupata strategicamente da forze regressive, e sostenerla significa, di fatto, portare acqua al mulino del neoliberismo. In poche parole: significa guerra. Un’immagine plastica di questa deriva è offerta dall’Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, che ignora il ruolo decisivo di Russia e Cina nella Seconda guerra mondiale e si fa fotografare sorridente su un carro armato ucraino.
La questione, dunque, non è scegliere tra federalismo e nazionalismo, ma ricostruire lo spazio europeo come luogo di cooperazione fra Stati e di internazionalismo, a partire da una ri-democratizzazione degli stessi spazi nazionali, sempre più svuotati dai meccanismi di governance finanziaria.
Ciò implica, in primo luogo, una critica radicale agli attuali dispositivi istituzionali: le modalità di produzione normativa, le fonti di legittimità, il rapporto tra cittadinanza e decisione.
Sovranità, pluralismo, differenziazione
Una tale ricostruzione non può avvenire se non si affronta la questione della sovranità. Il lessico politico contemporaneo ha, troppo spesso, contrapposto in modo meccanico sovranità nazionale e appartenenza europea, fingendo di ignorare che ogni trasferimento di potere comporta una nuova forma di legittimazione. Senza una ridefinizione condivisa di cosa significhi “decidere insieme”, il progetto europeo è destinato a rimanere fragile, esposto alla doppia trappola del centralismo tecnocratico e del sovranismo regressivo.
In questo contesto, risulta sempre più pertinente l’idea di un’Europa a geometria variabile: un sistema di cerchi concentrici, in cui coesistano diversi livelli di integrazione. Una configurazione differenziata non come compromesso al ribasso, ma come forma legittima di pluralismo istituzionale, capace di riflettere le diverse volontà politiche, le differenti tradizioni costituzionali e le eterogeneità economiche e sociali.
Tale modello avrebbe il vantaggio di evitare tanto la forzatura dell’uniformità quanto la disgregazione. Ma per funzionare richiede un quadro chiaro di diritti, competenze, responsabilità politiche: una nuova grammatica costituzionale europea che non esiste ancora, ma che potrebbe emergere proprio da una fase di crisi costituente e dopo aver disinquinato i pozzi dal neoliberalismo.
Oltre il mercato: l’Europa come spazio di civiltà
Per ripensare l’Unione, occorre superare la riduzione economicistica del progetto europeo. L’Europa non è – e non può essere – solo una costruzione giuridico-amministrativa o un’area di scambio regolato (tanto più se questo pone come fondamento il criterio concorrenziale dell’ordoliberalismo). Essa è anche un orizzonte di civiltà: un territorio culturale e simbolico, attraversato da conflitti, memorie, visioni del mondo.
Riconoscere questa dimensione significa accettare che l’unità europea non potrà mai essere un’unità omogenea, ma sarà sempre una composizione instabile, conflittuale, dialogica. Da qui l’urgenza di restituire centralità alle dimensioni politiche, culturali e nazionali della legittimazione: non basta “funzionare”, occorre anche “significare”. Le istituzioni europee non possono limitarsi a produrre regole: devono costruire senso, appartenenza, riconoscimento reciproco e ciò non può certo avvenire top/down, ma attraverso un processo che la società civile deve produrre.
Il futuro dell’Unione europea dipenderà dalla capacità di pensarsi non come fine della storia istituzionale, ma come campo aperto di trasformazione politica. In questa prospettiva, la vera questione non è se l’Europa sopravvivrà, ma quale Europa siamo disposti a costruire. In gioco non c’è solo il destino dell’Unione, ma il modo in cui pensiamo oggi la democrazia, la sovranità, l’autogoverno dei popoli in un mondo interdipendente. In questo senso, l’Europa è ancora un problema aperto e per questo, forse, il luogo più politico del nostro tempo.